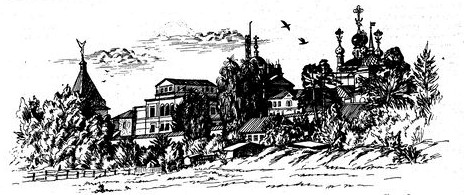I semina verbi nel contesto della globalizzazione. Tra Oriente ed Occidente

Con la sua teoria del λόγος σπερματικός Giustino getta un ponte tra la filosofia antica e il cristianesimo. In Cristo apparve, in tutta la sua pienezza, il Logos divino, ma ogni uomo possiede nella sua ragione un germe (σπέρμα) del Logos. Questa partecipazione al Logos, e conseguente disposizione a conoscere la Verità, fu in alcuni particolarmente grande; così nei profeti del giudaismo e, fra i greci, in Eraclito e Socrate. Berthold Altaner
La maggior parte di coloro che si sono occupati di Giustino scorgono in questo apologeta il primo esempio della teoria della praeparatio evangelica, espressione che sarà formulata pienamente da Clemente Alessandrino e da Eusebio di Cesarea. Quello che vale nell’esperienza dei singoli continua a valere negli stessi termini per i «contesti sociali-culturali»? In altri termini il fenomeno della globalizzazione rappresenta per l’evangelizzazione contemporanea il pericolo di una mondializzazione delle strutture di peccato, o apre il cuore del credente ad un terreno missionario sconfinato? I Semina Verbi sono ancora presenti ed attivi nella nostra contemporaneità? La fede viene ancora storicizzata nelle forme artistiche, filosofiche, nella carità politica, o rappresenta ormai una radice che non riesce a trasmettere linfa? (Cf. Giuseppe Girgenti, Giustino Martire. Il primo cristiano platonico, Vita e Pensiero, Milano 1995). Sono gli interrogativi di fronte a cui ogni cristiano è chiamato a spendere la fatica di pensare, sono gli interrogativi a cui cercherò di rispondere, o per lo meno a partire dai quali tenterò di imbastire un’argomentazione.
Mi sembra che la dinamica dell’annuncio del Vangelo e il “metodo” per rendere ragione della speranza cristiana (cf 1 Pt 3, 15ss) permangono nella storia pur mutando le situazioni e le contingenze particolari. Anche oggi la riflessione credente, come Paolo ad Atene, è chiamata ad annunciare e inculturare il vangelo proprio a partire dalla praeparatio evangelica. L’auditus temporis, ovvero l’ascolto vigile del proprio tempo diventa essenziale per mediare la verità cristiana nei diversi contesti culturali della storia. Interrogarsi sui semina verbi, significa operare un proficuo discernimento, operare un vaglio critico. «Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono» (1 Tess 5, 21), l’invito che Paolo lancia alla Chiesa di Tessalonica interpella ogni esperienza credente di ogni tempo e di ogni luogo.
I monaci nella loro fuga mundi conservano la cultura pagana salvando l’opera di Platone, Cicerone etc. In qualche modo percepivano il valore prodromico della cultura pagana. La fatica di scrutare i segni dei tempi, è un continuo travaglio che accomuna l’occidente con l’oriente. Non a caso Piero Coda annota a tal proposito:
La teologia orientale è una teologia che si fonda in maniera imprescindibile con e dalla Chiesa il cui cammino esodale accompagna nella dimensione dell’incompiuta pienezza del già e non ancora, della memoria e della profezia. L’oriente cristiano slavo non è nuovo ad interrogarsi sui caratteri della vera religio, il suo rapporto con il mondo sociale e le possibili derive demagogico-populiste. Una forma emblematica della religione globale potrebbe essere indicata nell’oscura e fantasmagorica figura del mago Apollonio, che il genio di Vladimir Solov’ëv ha descritto, agli albori del ‘900, nel suo Breve racconto dell’Anticristo:
Il filosofo italiano Emanuele Severino ha adottato della globalizzazione la definizione: «estenzione all’intero pianeta dell’economia capitalistica nel suo strutturarsi secondo le potenzialità della rete telematico-informatica». (E. Severino, «Globalizzazione e tradizione», in AA.VV, Filosofia (e critica della) globalizzazione, in MicroMega 5/2001, 108). Il altri termini la globalizzazione rappresenterebbe la dimensione sociale della vittoria del capitalismo. Ma non tutti condividono questa posizione, ci sono coloro che pensano che la globalizzazione rappresenti semplicemente uno stadio di sviluppo ulteriore del capitalismo. Una tale linea interpretativa si avvale di un celebre passo del Manifesto del 1848, in cui Marx ed Engel scrivono:
Ma a cosa ha portato il pensare che l’unità di un Paese potesse fondarsi esclusivamente sul suo bastare a sé stesso in un’autarchia che sconosce il mercato mondiale, anzi lo teme, viene magistralmente illustrato dal vescovo Hilarion Alfeyev sono parole donate come scrigno al tesoro del magistero del Sommo Pontefice Benedetto XVI:
Un interrogativo è doveroso a questo punto: la paura che faceva prendere le distanze a Marx ed Engel dal pericolo borghese di sottrarre alle industrie la base nazionale, non è forse la stessa paura mutatis mutandis che porta i vertici della gerarchia ecclesiale russa ad autocertificare un ruolo di coesione religioso maggioritario, con annessi diritti di visibilità e contrattualità rispetto alle derive laiciste che attraversano il loro Paese. La loro pretesa, non cavalca forse nuovamente l’ indomita paura che una crisi dell’identità nazionale, non certamente irrelata alla produzione industriale, ma al senso di appartenenza religiosa possa sfaldare la coesione sociale? Ma in questo caso non viene scalfita la libertà che sottende ogni esperienza religiosa? Tanto più se si considera che il ruolo della religiosità popolare non viene toccato minimamente dal testo dei «Fondamenti sociali della Chiesa Russa».
Per concludere faccio mio, ma in forma dubitativa l’affermazione di Del Noce: «L’ateismo si fa destino della modernità»? (A. Del Noce, Il problema dell’ateismo, Bologna, il Mulino, 1964). No! Come ha sottolineato il card. Angelo Scola: «Il cammino fin qui compiuto domanda ora un passo ulteriore: mostrare in tutta la sua portata la rilevanza pubblica dell’esperienza cristiana e quindi il suo apporto compiuto alla società plurale. Per questo è necessario guardarla dal suo profilo interno, cioè a partire dal nucleo costitutivo della sua proposta. L’esperienza cristiana, infatti, si pone in relazione indistinguibile, pur nella sua obiettiva discontinuità, con l’esperienza umana elementare che, nella sua radice ultima, è sempre esperienza religiosa». (A. Scola, Buone ragioni per la vita in comune. Religione, politica, economia, Milano, Mondadori, 2010).
Proprio questa battuta finale mi permette di formulare un interrogativo che interpella l’inizio della riflessione sulla globalizzazione. Il fenomeno della mondializzazione ricalca per certi aspetti il fenomeno che nell’Europa mediterranea di San Paolo prese il nome di koinè, fu la comunanza della lingua, appunto il greco della Koinè a favorire la diffusione dell’esperienza credente degli evangelisti e degli apostoli, fu l’impero romano a favorire di fatto gli spostamenti nelle diverse regioni dell’Impero. Il fenomeno della globalizzazione è davvero così estraneo al cristianesimo? È una pericolosa struttura di peccato? O rappresenta una formidabile opportunità dei nostri giorni?
Il magistero di Giovanni Paolo II più volte nella «Novo millennio ineunte» è tornato a rimarcare che la Chiesa è solo all’inizio dell’evangelizzazione e credo che il fenomeno della globalizzazione sia una provvidenziale opportunità dei nostri giorni, da vagliare criticamente certamente e ad ogni passo, ma di cui non aver timore.
Antonino Pileri Bruno
La maggior parte di coloro che si sono occupati di Giustino scorgono in questo apologeta il primo esempio della teoria della praeparatio evangelica, espressione che sarà formulata pienamente da Clemente Alessandrino e da Eusebio di Cesarea. Quello che vale nell’esperienza dei singoli continua a valere negli stessi termini per i «contesti sociali-culturali»? In altri termini il fenomeno della globalizzazione rappresenta per l’evangelizzazione contemporanea il pericolo di una mondializzazione delle strutture di peccato, o apre il cuore del credente ad un terreno missionario sconfinato? I Semina Verbi sono ancora presenti ed attivi nella nostra contemporaneità? La fede viene ancora storicizzata nelle forme artistiche, filosofiche, nella carità politica, o rappresenta ormai una radice che non riesce a trasmettere linfa? (Cf. Giuseppe Girgenti, Giustino Martire. Il primo cristiano platonico, Vita e Pensiero, Milano 1995). Sono gli interrogativi di fronte a cui ogni cristiano è chiamato a spendere la fatica di pensare, sono gli interrogativi a cui cercherò di rispondere, o per lo meno a partire dai quali tenterò di imbastire un’argomentazione.
Mi sembra che la dinamica dell’annuncio del Vangelo e il “metodo” per rendere ragione della speranza cristiana (cf 1 Pt 3, 15ss) permangono nella storia pur mutando le situazioni e le contingenze particolari. Anche oggi la riflessione credente, come Paolo ad Atene, è chiamata ad annunciare e inculturare il vangelo proprio a partire dalla praeparatio evangelica. L’auditus temporis, ovvero l’ascolto vigile del proprio tempo diventa essenziale per mediare la verità cristiana nei diversi contesti culturali della storia. Interrogarsi sui semina verbi, significa operare un proficuo discernimento, operare un vaglio critico. «Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono» (1 Tess 5, 21), l’invito che Paolo lancia alla Chiesa di Tessalonica interpella ogni esperienza credente di ogni tempo e di ogni luogo.
I monaci nella loro fuga mundi conservano la cultura pagana salvando l’opera di Platone, Cicerone etc. In qualche modo percepivano il valore prodromico della cultura pagana. La fatica di scrutare i segni dei tempi, è un continuo travaglio che accomuna l’occidente con l’oriente. Non a caso Piero Coda annota a tal proposito:
La teologia morale ortodossa si trova oggi di fronte alla necessità di rispondere a nuove e inusitate sfide etiche. Da una parte, le Chiese orientali della diaspora condividono gli stessi problemi delle chiese occidentali; interpellate da uno sviluppo tecnologico frenetico e da profonde trasformazioni socioculturali, devono anch’esse dare precise e specifiche risposte in ambito bioetico, sociale, culturale. Dall’ altra, la fine dei regimi comunisti nei paesi dell’Est ha provocato in gran parte delle Chiese ortodosse, quelle slave e quella romena, la necessità di elaborare più adeguatamente la propria visione della società e dello Stato, così come il ruolo delle chiese nelle nuove comunità nazionali. (cf. Giacomo Canobbio – Piero Coda edd, La teologia del XX secolo un bilancio. 3. Prospettive pratiche, Citta Nuova, Roma 2003).
La teologia orientale è una teologia che si fonda in maniera imprescindibile con e dalla Chiesa il cui cammino esodale accompagna nella dimensione dell’incompiuta pienezza del già e non ancora, della memoria e della profezia. L’oriente cristiano slavo non è nuovo ad interrogarsi sui caratteri della vera religio, il suo rapporto con il mondo sociale e le possibili derive demagogico-populiste. Una forma emblematica della religione globale potrebbe essere indicata nell’oscura e fantasmagorica figura del mago Apollonio, che il genio di Vladimir Solov’ëv ha descritto, agli albori del ‘900, nel suo Breve racconto dell’Anticristo:
Proveniente dall’estremo Oriente e circondato da una fitta nube di strane avventure e di bizzarri racconti fiabeschi, uomo senza dubbio di genio, metà asiatico metà europeo, vescovo cattolico in partibus infidelium, riuniva in sé in modo meraviglioso il possesso delle conclusioni più recenti e delle applicazioni tecniche della scienza occidentale, con la conoscenza e la capacità di servirsi di tutto ciò che è veramente fondato e importante del misticismo tradizionale dell’Oriente. Strabilianti saranno i risultati di una combinazione di tal genere. (V. Solov’ëv, I tre dialoghi e il racconto dell’Anticristo, Marietti, Genova 19962, 178-179).
Il filosofo italiano Emanuele Severino ha adottato della globalizzazione la definizione: «estenzione all’intero pianeta dell’economia capitalistica nel suo strutturarsi secondo le potenzialità della rete telematico-informatica». (E. Severino, «Globalizzazione e tradizione», in AA.VV, Filosofia (e critica della) globalizzazione, in MicroMega 5/2001, 108). Il altri termini la globalizzazione rappresenterebbe la dimensione sociale della vittoria del capitalismo. Ma non tutti condividono questa posizione, ci sono coloro che pensano che la globalizzazione rappresenti semplicemente uno stadio di sviluppo ulteriore del capitalismo. Una tale linea interpretativa si avvale di un celebre passo del Manifesto del 1848, in cui Marx ed Engel scrivono:
Sfruttando il mercato mondiale la borghesia ha reso cosmopoliti la produzione e il consumo di tutti i Paesi. Con gran dispiacere dei reazionari, ha tolto all’industria la base nazionale. Le antichissime industrie nazionali sono state e vengono di giorno in giorno, smantellate. Esse vengono soppiantate da nuove industrie, la cui introduzione è questione di vita o di morte per tutte le nazioni civili (…). In luogo dell’antico isolamento locale e nazionale, per cui ogni Paese bastava a se stesso, subentra un traffico universale, una universale dipendenza delle nazioni l’una dall’altra. (K. Marx-F. Engel, Il manifesto del Partito Comunista, Editori Riunniti, Roma 1972, 43).
Ma a cosa ha portato il pensare che l’unità di un Paese potesse fondarsi esclusivamente sul suo bastare a sé stesso in un’autarchia che sconosce il mercato mondiale, anzi lo teme, viene magistralmente illustrato dal vescovo Hilarion Alfeyev sono parole donate come scrigno al tesoro del magistero del Sommo Pontefice Benedetto XVI:
Nell'Unione Sovietica la religione fu perseguitata per settant'anni. Vi furono diverse ondate di persecuzione, e ognuna ebbe un suo particolare carattere. Negli ultimi anni Venti e negli anni Trenta, le persecuzioni furono più crudeli. Gran parte del clero fu messa a morte; tutti i monasteri, le scuole teologiche e la maggioranza delle chiese furono chiuse. Un periodo meno brutale seguì alla fine della seconda guerra mondiale, quando alcuni monasteri furono riaperti insieme a qualche scuola. Negli anni Sessanta, ebbe inizio una nuova ondata di severe persecuzioni, che mirava al totale annientamento della religione che avrebbe dovuto compiersi entro l'inizio degli anni Ottanta.
A metà degli anni Ottanta, però, la Chiesa non solo era ancora viva ma, di fatto, per quanto lentamente, essa stava crescendo. [...] Una cosa, tuttavia, non mutò mai: il divieto comminato alla religione di uscire da quel ghetto nel quale era stata confinata dal regime ateo. [...]
Ora, i processi che attualmente hanno luogo in Europa hanno qualche somiglianza con quelli nell'Unione Sovietica. Per la religione, il secolarismo militante è tanto pericoloso quanto lo fu l'ateismo militante. Tendono entrambi a escludere la religione dalla sfera pubblica e politica, relegandola in un ghetto, confinandola nell'ambito della devozione privata. Le regole non scritte di "political correctness" vengono sempre più spesso applicate alle istituzioni religiose. In tanti casi ciò implica il fatto che i credenti non possono più esprimere le loro convinzioni apertamente, in quanto l'esprimere pubblicamente la propria convinzione religiosa potrebbe essere considerata una violazione dei diritti di coloro che non la condividono. [...]
I risultati di questa politica sono evidenti. In alcuni paesi, specialmente quelli che non sono a maggioranza cattolica od ortodossa, le maestose cattedrali che sino qualche decennio fa contenevano migliaia di fedeli in preghiera sono semivuote; i seminari teologici chiudono per mancanza di vocazioni; le comunità religiose non si rinnovano; le proprietà delle Chiese sono vendute; i luoghi di culto trasformati in centri per attività mondane. Ancora una volta è innegabile che in tanti casi sono le Chiese stesse responsabili della situazione, ma l'effetto distruttivo del secolarismo non va sottovalutato. La religione è realmente espulsa dalla sfera pubblica, sempre più marginalizzata dalla società secolarizzata. E questo nonostante il fatto che in tutto l'Occidente e in Europa in particolare la maggior parte della gente creda ancora in Dio. (Hilarion Alfeyev, L'aiuto che la Chiesa ortodossa russa può dare all'Europa, Introduzione a Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, "Europa, patria spirituale", Mosca/Roma, 2009).
Un interrogativo è doveroso a questo punto: la paura che faceva prendere le distanze a Marx ed Engel dal pericolo borghese di sottrarre alle industrie la base nazionale, non è forse la stessa paura mutatis mutandis che porta i vertici della gerarchia ecclesiale russa ad autocertificare un ruolo di coesione religioso maggioritario, con annessi diritti di visibilità e contrattualità rispetto alle derive laiciste che attraversano il loro Paese. La loro pretesa, non cavalca forse nuovamente l’ indomita paura che una crisi dell’identità nazionale, non certamente irrelata alla produzione industriale, ma al senso di appartenenza religiosa possa sfaldare la coesione sociale? Ma in questo caso non viene scalfita la libertà che sottende ogni esperienza religiosa? Tanto più se si considera che il ruolo della religiosità popolare non viene toccato minimamente dal testo dei «Fondamenti sociali della Chiesa Russa».
Per concludere faccio mio, ma in forma dubitativa l’affermazione di Del Noce: «L’ateismo si fa destino della modernità»? (A. Del Noce, Il problema dell’ateismo, Bologna, il Mulino, 1964). No! Come ha sottolineato il card. Angelo Scola: «Il cammino fin qui compiuto domanda ora un passo ulteriore: mostrare in tutta la sua portata la rilevanza pubblica dell’esperienza cristiana e quindi il suo apporto compiuto alla società plurale. Per questo è necessario guardarla dal suo profilo interno, cioè a partire dal nucleo costitutivo della sua proposta. L’esperienza cristiana, infatti, si pone in relazione indistinguibile, pur nella sua obiettiva discontinuità, con l’esperienza umana elementare che, nella sua radice ultima, è sempre esperienza religiosa». (A. Scola, Buone ragioni per la vita in comune. Religione, politica, economia, Milano, Mondadori, 2010).
Proprio questa battuta finale mi permette di formulare un interrogativo che interpella l’inizio della riflessione sulla globalizzazione. Il fenomeno della mondializzazione ricalca per certi aspetti il fenomeno che nell’Europa mediterranea di San Paolo prese il nome di koinè, fu la comunanza della lingua, appunto il greco della Koinè a favorire la diffusione dell’esperienza credente degli evangelisti e degli apostoli, fu l’impero romano a favorire di fatto gli spostamenti nelle diverse regioni dell’Impero. Il fenomeno della globalizzazione è davvero così estraneo al cristianesimo? È una pericolosa struttura di peccato? O rappresenta una formidabile opportunità dei nostri giorni?
Il magistero di Giovanni Paolo II più volte nella «Novo millennio ineunte» è tornato a rimarcare che la Chiesa è solo all’inizio dell’evangelizzazione e credo che il fenomeno della globalizzazione sia una provvidenziale opportunità dei nostri giorni, da vagliare criticamente certamente e ad ogni passo, ma di cui non aver timore.
Antonino Pileri Bruno