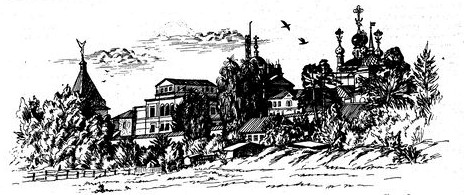Cultura e Chiesa nella teologia orientale contemporanea

A colui che è abituato considerare ponderatamente la realtà circostante e dare ascolto all’autentica voce della vita, [...], difficilmente sembrerà inaspettato e discutibile affermare che nel contesto spirituale dell’uomo contemporaneo già da lungo tempo qualcosa non va, che matura una certa crisi, forse presagio di una svolta sul punto di accadere. Questa crisi è stata preparata da tutta la storia moderna. Sergeij Bulgakov.
La cultura contemporanea è segnata dalla visione scientista che vede nella tecnica il fine ultimo a cui tende e per certi versi identifica la stessa scienza con la tecnica. Dall’Illuminismo muta l’autocoscienza dell’uomo che identifica il suo stesso essere con la mera funzione raziocinante del pensiero, questa posizione è emblematicamente espressa dall’espressione cartesiana del «cogito ergo sum». I fermenti dell’Illuminismo, vennero nell’Ottocento, elaborati dalla speculazione filosofica di Auguste Comte. Comte è consapevole di appartenere ad un epoca di transizione, di passaggio da un modello di società di stampo medioevale basato a suo modo di vedere su una particolare partnership tra il potere spirituale e il potere militare, ad una società industriale, basata non più sulla conquista ed il mantenimento dello status quo ma sulla produzione.
Si noti bene il dramma che si matura in questa temperie culturale che prende le mosse dal razionalismo, la società che si intende costruire getterà le sue basi sugli stessi “due poteri”, lo spirituale e il temporale, ma con un mutamento dei quadri di riferimento per cui al potere feudale medioevale si sostituirà la «capacità industriale», mentre la «capacità tecnico-scientifica» sostituirà il potere spirituale ecclesiale. In questo progetto di nequizia il «potere della dimostrazione» avrebbe dovuto scalzare il «potere della rivelazione». (cf. Considerazione sommarie dell’insieme del passato moderno, 1820).
Facciamo nostra l’espressione di Adorno Horkheimer sugli esiti nefasti dell’Illuminismo : «Ma la terra interamente illuminata splende all’insegna di trionfale sventura» (cf. Dialettica dell’Illuminismo). La riflessione di Karl Popper ha scalzato le argomentazioni del razionalismo: la scienza come “nuova religione” non esiste, la scienza è solo ricostruzione della realtà; ma si badi bene, emergono in Popper echi del pensiero di Agostino. Secondo il vescovo di Ippona mentre la scienza è la capacità di ordinare le cose, la sapienza è la capacità di conoscere i fini.
La nostra scienza è Cristo, la nostra sapienza è ancora Cristo. È Lui che introduce in noi la fede che concerne le cose temporali, Lui che ci rivela la verità concernente le cose terrene. Per mezzo di Lui andiamo a Lui, per mezzo della scienza tendiamo alla sapienza; senza tuttavia allontanarci dal solo medesimo Cristo in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza, [De Trinitate 13, 19, 24]. Chiamiamo propriamente sapienza la scienza delle cose divine e riserviamo propriamente il nome di scienza alla conoscenza delle cose umane. Di questa ho già parlato, non attribuendo certamente alla scienza tutto ciò che l’uomo può sapere circa le cose umane, in cui si trova tanta vanità superflua e pericolosa curiosità, ma solo la conoscenza che genera, nutre, difende e fortifica la fede supremamente salutare, che conduce l’uomo alla vera beatitudine... Altro è sapere appena quello che un uomo deve credere per conseguire la vita beata, la quale non può essere se non eterna, altro è saperlo in tal modo da metterlo a profitto dei buoni [...]. (De Trinitate 14, 1, 3).
È un cammino di allontanamento, quello tra la fede e la ragione che Bulgakov sembra imputare ad un umanesimo troppo schiacciato su una dimensione che paganeggiante dell’uomo e avulso dalla visione cristiana dell’uomo.
A partire dalla fine del medioevo, la vita spirituale dell’umanità, dopo aver compiuto miracoli incredibili di tecnica e di cultura materiale in genere mai visti nella storia, ed aver maturato ad un grado senza precedenti la conoscenza scientifica, in particolare le scienze esatte, manifestando una ampiezza mai vista di creatività sociale, sviluppando fino ad una acutezza ed una finezza eccezionali il pensiero filosofico, creando un’arte possente nei suoi diversi rami, tutta questa vita spirituale si è sviluppata sotto il segno di un principio unilateralmente umano, anti divino, ha coltivato insegnamenti di umanesimo unilaterale e astratto. In questo senso, a tutto questo cosiddetto tempo moderno va attribuito il nome con cui è chiamata solo una delle sue epoche iniziali: il secolo dell’umanesimo, nel senso puramente naturalistico e pagano, nel senso della rivolta dell’umanità cosciente della sua forza contro la visione del mondo ascetica del medioevo – erroneamente confusa con l’autentico cristianesimo, cioè con il cristianesimo universale-, contro il clericalismo medioevale inquisitorio, considerato altrettanto erroneamente come la Chiesa di Cristo […] L’umanità l’ha fatta finita con la tutela patriarcale ed ha abbandonato per sempre le opprimenti, anche se maestose, volte della gotica medioevale. Il figlio prende la sua parte di eredità e lascia la casa del padre, partendo per un “paese lontano” dove vivere nella libertà». (Lo spirituale della cultura, 39-40).
Il giudizio di Bulgakov, non è chiuso alla speranza, al contrario egli è aperto e speranzoso sulla capacità di ravvedimento dell’uomo. «Il figlio prodigo contemporaneo comincia solo a, malapena e segretamente, nella profondità dell’anima, ed avere nostalgia della patria abbandonata e, forse, non è ancora vicino il tempo in cui egli compirà l’atto dell’auto rinuncia spirituale, vincerà la sua spasmodica autoaffermazione e dirà: Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te », (cf. Lo spirituale della cultura, 40). È proprio la presa di coscienza del tesoro perduto che muove, secondo il teologo russo, alla conversione, è pesante l’espressione di Bulgakov, e per certi versi ricalca temi che la nostra pubblicistica contemporanea riscopre, mi riferisco al tema delle radici cristiane dell’Europa: «Tutta la cultura contemporanea, cresciuta come un albero lussureggiante e possente, comincia ad avvizzire e a sbiadire per la mancanza delle profonde radici di un nutrimento mistico-religioso». (cf. Lo spirituale della cultura, 41). È il tema dell’evangelizzazione che vivifica il rapporto Chiesa-Mondo, ed è la carità culturale che apre canali fecondi in cui la Tradizione e la contemporaneità gettano i ponti del loro futuro. Marko Rupnik declina questa tematica con parole piene di saggezza.
L’evangelizzazione non può dunque che cominciare con l’aspetto culturale, con una testimonianza della carità, cioè una sana relazionalità con delle persone concrete, nella consapevolezza tuttavia che neanche la cultura dell’evangelizzazione rappresenta ciò che annuncia in un modo esauriente. Ma poiché la sostanza dell’incontro interculturale è una relazione nella carità tra le persone – e la carità si realizza nella pasqua e vive in modo pasquale-, anche il cambiamento della cultura che avviene nell’evangelizzazione deve andare al ritmo della pasqua. Questa dinamica coinvolge sia l’evangelizzato che l’evangelizzatore». (Marko I. Rupnik in Tomas Spidlik et al. Teologia pastorale a partire dalla bellezza, Lipa: Roma, 2005, 42).
Ma Chiesa non è estranea al mondo, al contrario vive in stretta condivisione con le speranze e le attese del mondo, proprio per questo può accompagnare la strada dei propri fratelli, la strada che conduce alla strada del Padre.
Perciò, come amore e senza alterigia, ma con umiltà cristiana, bisogna aprire il proprio cuore al mondo “laico”. E forse quella volta anche il fratello maggiore insieme al Padre aspetterà il giorno gioioso in cui vedrà che il figlio prodigo era morto ed è tornato alla vita, era perduto ed è stato ritrovato. Sia da una parte che dall’altra va riconosciuta la colpa reciproca e va fatto un sacrificio spirituale: allora nascerà naturalmente un’attrazione reciproca e si ricostituirà davvero una Chiesa militante viva, creativa, che aspira alla città futura. “Sto alla porta e busso” -Ap 3, 20. (Lo spirituale della cultura, 49)
Antonino Pileri Bruno