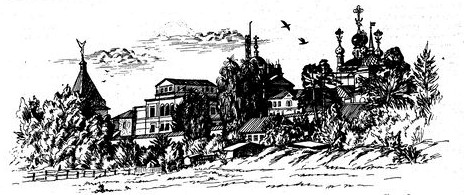Cirillo e Metodio apostoli del Vangelo nella cultura slava

Bizantini di cultura, i fratelli Cirillo e Metodio seppero farsi apostoli degli Slavi nel pieno senso della parola. La separazione dalla patria che Dio talvolta esige dagli uomini eletti, accettata per la fede nella sua promessa, è sempre una misteriosa e fertile condizione per lo sviluppo e la crescita del Popolo di Dio sulla terra. Dalla lettera «Slavorum apostoli» di Giovanni Paolo II
Fino al secolo VII essere cristiani significa fare parte dell'Impero o per lo meno gravitare sotto la sua protezione. Lo sviluppo del cristianesimo oltre i confini è generalmente lasciato all'iniziativa dei singoli fedeli cristiani. La gerarchia ecclesiastica agisce istituzionalmente solo dopo la fondazione di una Chiesa in paese straniero, per consacrare un vescovo. È una situazione questa che sembra appiattire l'identità religiosa a quella socio-politica, ben presto qualcosa cambia, sono due fratelli di Salonicco a mettere in moto un cambio di marcia che non conoscerà mai più ripensamenti.
Si sa che l'antico idelae di pax romana per una civiltà unica nell'unico regno mediterraneo cominciò a crollare quando Diocleziano nell'anno 286 divise l'impero in due parti, l'occidentale e l'orientale, con due “cesari” diversi. Queste due parti dell' oikouméne, terra civilizzata, cominciarono a diversificarsi e ad opporsi proprio nel momento in cui i nuovi popoli “barbarici” entrarono sulla scena del mondo conosciuto. Questi nuovi popoli divennero allora cristiani occidentali ed orientali, appartenenti quindi a due culture diverse. Nel secolo IX la separazione delle Chiese diventò quasi un fatto compiuto. Ed è appunto in quel tempo che vengono battezzati i popoli slavi, una grande massa di forze nuove che si collocano proprio nel mezzo delle due parti del mondo. Fin dall'inizio sorse la domanda: apparterranno all'occidente o all'oriente? I santi Cirillo e Metodio furono greci mandati dall'imperatore di Costantinopoli nel territorio dell'Europa centrale, dove già valoravano dei missionari occidentali. Sembrava quindi inevitabile un conflitto. Ma apparve anche una soluzione del tutto nuova e, per quel tempo, inaspettatamente moderna. Anche se venuti dall'oriente, i due missionari si recarono a Roma. Ed a Roma accadde una cosa che può essere definita un miracolo, un segno dei tempi. Nonostante le obiezioni levate da tutte le parti, il papa affida a Metodio l'incarico di fondare una “Chiesa del centro”, né orientale, né occidentale, con una lingua liturgica propria, destinata a creare una propria tradizione. Se l'impresa fosse riuscita, il volto della Chiesa universale sarebbe oggi diverso. Non sarebbe nata quella millenaria opposizione fra la Chiesa vivente nella cultura latina da una parte e tutto il resto del mondo dall'altra. Ma il grande progetto fallì. Le ragioni sono le più diverse; hanno però un denominatore comune: gli slavi entrarono in un mondo cristiano diviso ed essi stessi furono divisi, quasi tagliati a metà in slavi occidentali – con cultura latina – e slavi orientali, inseriti nella cultura greca. Invece di contribuire alla conciliazione della Chiesa d'occidente con quella d'oriente, essi vivono ancora oggi l'antagonismo dello scisma sul proprio corpo. Il grande esperimento missionario si risolse quindi in un fallimento: così almeno sembrava. Eppure, non del tutto. È rimasta una cosa importante: la liturgia slava e, anche nei paesi di rito latino, la tradizione di molti canti e di “paraliturgie” nella propria lingua, l'amore di “lodare Dio con la propria lingua”. (Tomas Spidlik, Miscellanea I. Alle fonti dell'Europa, Lipa, Roma 2004, 15-16).
Il dono dell'alfabetto, incide nell'autocomprensione del popolo slavo, che comincia a definirsi come l'operaio dell'ultima ora. La dinamica missionaria che si viene a realizzare opera su due moduli, da una parte l'alfabeto media l'inculturazione della fede cristiana presso i popoli slavi, dall'altra il glagolitico dona a questi popoli la possibilità di entrare nella storia della cultura mondiale.
Operai dell' ultima ora” solevano definirsi gli Slavi di fede ortodossa per la loro tardiva conversione. La Grazia li aveva illuminati fra gli ultimi lustri del secolo IX ( il Primo impero di Bulgaria) e la vigilia del Mille (la Rus' kieviana), con un ritardo plurisecolare rispetto all'epoca dell'incarnazione del Verbo. L'evento che segnava anche il loro ingresso nella storia dell'umano genere tramandata dalle Sacre Scritture e insieme in quello dell'ecumene cristiana. Fra i tanti repentini cambiamenti radicali, che la conversione alla fede cristiana apportò alla loro esistenza svetta la scoperta delle litterae, che a breve avrebbe favorito la nascita di due ragguardevoli tradizioni scrittorie, rispettivamente a Occidente e a Oriente del Ponto. (Alda Giambelluca Kossova, Ad erudendam fidelium plebem. Esegesi dei primi sunti scritturali paleoslavi (ss. IX-XI), Edizioni Lussografica, Caltanissetta, 2010 p. 9).
Tra l'860-63 Rotislav dichiarò: «il nostro popolo ha respinto il paganesimo e osserva le leggi cristiane, però non abbiamo una maestro tale che sia in grado di spiegarci la vera fede cristiana nella nostra lingua, affinchè anche le altre regioni (slave), vedendolo, seguano il nostro esempio. Inviateci pertanto, Signore, un tale vescovo e maestro. Da voi, infatti, emana sempre una legge valida per tutto l'ecumene». (VC, 14). Rostislav chiede per il suo popolo la religione cristiana come «cultura». Le offerte si sottomissione filiale offerte da Cirillo e Metodio a Roma, non bastano a frenare segni di inquietudine. Nell'inverno del 867, dopo quattro anni di missione morava giungono a Venezia e vengono esposti ad un contraddittorio in cui il clero locale mostra tutta la sua ostilità. In questi termini ne parla la Vita di Costantino-Cirillo:
Si radunarono contro di lui vescovi, preti e monaci, come corvi contro un falco e sollevarono l'eresia delle tre lingue dicendo: senti tu: dicci perchè ora tu hai composto l'alfabeto per gli slavi e lo insegni [loro]. Ciò non venne escogitato prima da nessuno, né da Gregorio Magno, né da Girolamo, né da Agostino. Noi non conosciamo che le tre lingue nelle quali è lecito lodare Dio: l'ebraico, il greco ed il latino. (La Vita di Costantino-Cirillo 16, 2-3, trad. V Peri, Milano 1981, 93).
Le cose mutano appena i santi fratelli si recano presso il papa Adriano II, questi riceve con grande gioia dalle loro mani le reliquie di san Clemente ed autorizza che la liturgia venga ufficiata in lingua slava, chiede soltanto che l'epistola ed il vangelo siano lette prima in latino, per salvaguardare l'uso generale.
Quando, però, nel 869, Metodio torna da solo in Moravia, la situazione si deteriora e la posizione pontificia si irrigidisce. Giovanni VIII scrive a Metodio nel 873; poi lo convoca nel 879, rimproverandolo di celebrare la liturgia in «barbara id est slavina lingua».
Metodio, giunto a Roma, chiarisce il suo agire con il papa che annulla le decisioni prese «Colui infatti che ha creato le tre lingue principali, l'ebraico, il greco e il latino - scrive – ha anche creato le altre lingue». Ma Stefano V proibisce nuovamente, sotto pena di scomunica, di celebrare la messa in slavone, accordando solamente il permesso di tradurre e spiegare nella lingua vernacolare l'apostolo e il vangelo. Alla morte di Metodio, i suoi discepoli vengono espulsi ed i rapporti tra Roma e Costantinopoli verranno avvelenati dalla questione bulgara. L' importanza del lavoro di evangelizzazione dei due santi fratelli è stata portata a maturazione dal magistero di Giovanni Paolo II, il quale ben consapevole del ruolo che Cirillo e Metodio hanno assunto nella coesione dell'europa centro-orientale li ha posti come conpatroni d'Europa, è suggestivo rileggere l'articolo di Maccarrone, pubblicato in quell'occasione dall'Osservatore Romano:
Metodio, giunto a Roma, chiarisce il suo agire con il papa che annulla le decisioni prese «Colui infatti che ha creato le tre lingue principali, l'ebraico, il greco e il latino - scrive – ha anche creato le altre lingue». Ma Stefano V proibisce nuovamente, sotto pena di scomunica, di celebrare la messa in slavone, accordando solamente il permesso di tradurre e spiegare nella lingua vernacolare l'apostolo e il vangelo. Alla morte di Metodio, i suoi discepoli vengono espulsi ed i rapporti tra Roma e Costantinopoli verranno avvelenati dalla questione bulgara. L' importanza del lavoro di evangelizzazione dei due santi fratelli è stata portata a maturazione dal magistero di Giovanni Paolo II, il quale ben consapevole del ruolo che Cirillo e Metodio hanno assunto nella coesione dell'europa centro-orientale li ha posti come conpatroni d'Europa, è suggestivo rileggere l'articolo di Maccarrone, pubblicato in quell'occasione dall'Osservatore Romano:
Oggi Giovanni Paolo II, in un contesto ecclesiale e storico più ampio, al termine dell'anno centenario di San Benedetto, pone a fianco del Patriarca dell'Occidente i due Apostoli degli Slavi, con lo stesso titolo e la medesima funzione: l'Europa, di cui sono stati l'uno e gli altri in maniere e tempi diversi i costruttori, viene affidata al loro Patrocinio, proclamati dalla Chiesa Compatroni dell'Europa. [...] Quali sono i titoli, che giustificano agli occhi di oggi tale proclamazione? La vita dei due Santi è tanto lontana nel tempo, non è familiare come quella di San Benedetto. Bisogna riscoprirla, traendola alla luce dai libri degli studiosi, che con ampiezza e vigilanza critica si sono dedicati, specie nei tempi recenti e da diverse parti, cattolici ed ortodossi, all'esplorazione delle fonti ed alla ricostruzione della loro opera. Sulla base di tali studi si può delineare la figura e l'attività dei due Santi».[...] «I due Apostoli degli Slavi – continua Maccarrone – tornano oggi a noi, incoronati di una nuova missione. Essi devono vegliare sull'Europa, che li invoca come Patroni. Hanno rappresentato l'Europa con la loro vita e le loro missioni. Costaninopoli e Roma, le grandi capitali di allora, sono state le loro patrie ideali congiunte e unite dalla loro mediazione». Hanno dialogato, infatti, con i Saraceni, guidando la missione religioso-diplomatica inviata da Costantinopoli al califfo di Samarra. Hanno polemizzato con gli Ebrei presso i cazari, tra la Crimea ed il Caucaso (VC, 6 e 8-12). Hanno infine lavorato nell'Europa centrale, sul Danubio, e visitato Roma... «La loro Europa era un'Europa universalistica, aperta oltre i suoi confini geografici... A questa Europa i due apostoli hanno cercato di dare una sua unità spirituale, fondata sull'unico e comune Vangelo, nel rispetto e nella ricchezza della sua pluralità di lingue e di nazioni. Proprio per tale loro ideale, realizato nella loro azione, evangelizzatrice e pastorale, furono contrastati e sopraffatti dalle forze dell'egemonia e dell'individualismo. (Michele Maccarrone, Gli Apostoli degli Slavi Cirillo e Metodio compatroni d'Europa, «L'Osservatore Romano», 1 gennaio 1981).
All'inizio del terzio millennio di evangelizzazione hanno ancora tanto da dire ed insegnare i santi fratelli, ma un punto fra tutti è quello che spicca nella loro vicenda esistenziale, l'evangelizzazione, è da essi principalmente intesa come opera culturale, è proprio la possibilità di darsi una cultura che Cirillo e Metodio offrono ai popoli slavi, ed insieme alle lettere glagolitiche, la possibilità di avere una coscienza storica. Nei paesi slavi, il cristianesimo si presenta fin dal principio come una cultura, una disciplina di regole, in breve una civiltà.
Antonino Pileri Bruno