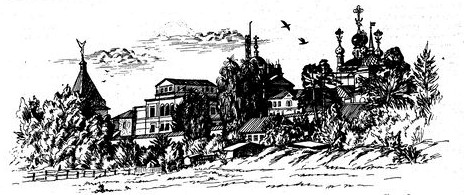Visione e Parola nella lettura teologica del Duomo di Monreale

Propongo alla lettura un mio articolo comparso in: "Monreale e la sua cattedrale: Novellare normanno nel segno di Guglielmo", Officina Studi Medioevali, Palermo 2011
La riflessione che intendo offrire muove le proprie considerazioni da una frase, piena di sacro stupore, del veggente di Patmos: «Mi voltai per vedere la voce che parlava con me» (Ap 1, 12). Il rapporto tra la parola e l’immagine è stato da sempre riconosciuto dalla Chiesa come una sinergia formidabile. L’accostamento tra il verbo “vedere” e il suo oggetto (la voce) non è dettato da audacia retorica; Giovanni poco prima ha detto: «(Questi) testimoniò la parola del Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, cose tutte che vide » (v. 2). Giovanni è colui che ha visto realmente incarnata la parola di Dio e la testimonianza di Gesù; proprio per questo conosce la voce del Pastore. (Cf. Bruno Forte, Apocalisse, Cinisello Balsamo (MI): Edizioni San Paolo 2000, 7-12).
La parola è presentata come oggetto della visione; perché? Mentre il senso comune percepisce la parola come l’esito di una locuzione verbale portatrice di senso, che mette in gioco solo la nostra capacità di cognizione concettuale, la visione è capace di chiamare in appello tutta la nostra capacità di coscienza percettiva. La visione crea un luogo in cui i nostri sensi sono convogliati e in un certo senso prendono vita; in questo modo l’immagine riconfigura l’habitat in cui l’uomo vive ed agisce.
È proprio questa l’esperienza che, in maniera consapevole o meno, condividiamo con Giovanni, non appena entriamo nella Cattedrale di Monreale: voltarci per vedere la voce che ci parla! Con tutta la portata, anche morale, che la parola voltarci porta in sé (mi riferisco al termine conversione). Il Duomo di Monreale celebra chiaramente l’onnipotenza di Dio nella creazione e in tutta la historia salutis, ma nello stesso tempo declina, nel succedersi delle sequenze iconiche, la dignità dell’uomo, che proprio perché fatto ad immagine e somiglianza di Dio rappresenta la Sua autorità nel mondo. L’uomo è legame tra Dio e il mondo creato, svolge così una triplice funzione: unitiva, cultica, di rivelazione. La dimensione unitiva, in quanto egli è culmine della creazione, ma al tempo stesso è fatto per Dio; la funzione cultica deriva dal fatto che il mondo servendo l’uomo rende culto a Dio; pensate, anche gli angeli! è proprio questo il senso della corona angelica che cinge la navata centrale e accompagna lo svolgersi delle scene della creazione; infine la funzione di rivelazione: l’uomo diventa il tipos di Cristo e annunciatore di Dio nel cosmo. A tal proposito risulta emblematica l’immagine della creazione di Adamo, in cui Cristo ed Adamo appaiono come figure speculari; immagine e somiglianza fin’anche nella postura (Si confronti Col. 1, 15: «(Cristo) è immagine di Dio invisibile, il primogenito di tutta la creazione»).
Il rapporto tra fede e arte è un rapporto di reciproca co-implicazione: l’arte si lascia ispirare dalla fede e la fede si lascia veicolare dall’arte. (Cf. Massimo Naro, Guardare la fede, in Il Duomo di Monreale. Lo splendore dei mosaici, testi di D. Abulafia e M. Naro, Libreria Editrice Vaticana - Itaca: Città del Vaticano - Castel Bolognese 2009, pp. 35-65) Se è vero che «uno dei caratteri più distintivi del cristianesimo è di proporre, accanto a un culto e a una dottrina morale, anche una complessa elaborazione teologica». (Cf. Manlio Simonetti, Le controversie cristologiche dal secondo al quarto secolo, in Studi di cristologia postnicena, Istitutum Patristicum Augustinianum: Roma, 2006, p. 1), è altrettanto vero che l’arte rappresenta l’espressione eminente della possibilità di sintesi di queste tre istanze.
Cosa distingue, il godimento che nasce dell’ammirazione artistica di una qualsiasi opera frutto dell’estro umano, dalla contemplazione in cui ci immerge lo stupore orante in questo Duomo? Mentre in un normale impianto prospettico le immagini, figurate in un’opera d’arte, convergono idealmente in un punto di fuga, qui invece, circondati da un impianto musivo che è nel suo complesso opera unitaria, la nostra esperienza sensoriale ci fa prendere atto di come in realtà siamo noi ad essere la linea di fuga in una prospettiva che è rovesciata, in quanto il punto di vista, non è solo il nostro. Il nostro sguardo in realtà incontra altri sguardi, sono gli sguardi della Madre di Dio, dei Santi, degli angeli, soprattutto è lo sguardo del Pantocrator, che sorregge tutto il cosmo e tutti i nostri sguardi (Cf. Pavel Florenskij, La prospettiva rovesciata e altri scritti, trad. it. a cura di C. Muschio e N. Misler, Casa del libro: Roma 1983).
L’estetica risulta così chiaramente, l’Altro esce da se (ex-tasis) per darsi in un incontro che è personale. L’intelligenza delle cose si esprime attraverso l’esperienza sensibile, che mai può essere ridotta a pura sensorialità (emozione, eccitazione del momento). L’incontro tra sacro e arte permette alla nostra sensibilità (uni-totalità del nostro essere) di entrare in relazione con la trascendenza.
La bellezza è il luogo in cui abita il vero e l’uno, proprio per questo non ammette falsità. La portata di questo mistero è appena intravista dal semplice turista che assiste con mero interesse culturale, il suo senso viene dispiegato nella liturgia, in un modo tale che ha tutti noi è dato di potere fare l’esperienza dei ministri mandati dal principe della Rus’. Vladimiro di Kiev, indagando tra tutte le religioni quale fosse la vera, scrive: «Recatici dai Greci fummo condotti laddove ufficiavano al proprio Dio. Non è possibile dire se ci si trovava in cielo o in terra, ché non v‘è sulla terra una simile visione, né una tale bellezza; siamo incapaci di narrare, ma e solo questo sappiamo, che in quel luogo Iddio convive con gli uomini e che il loro ufficio è superiore a quello di tutte le altre nazioni. Non è possibile per noi dimenticare tale bellezza; ogni uomo che ha assaporato la dolcezza l’amaro poi disdegna; similmente anche noi qui non possiamo più vivere » (Alda Giambelluca Kossova, Ad erudendam fidelium plebem. Esegesi dei primi sunti scritturali paleoslavi (ss. IX-XI), Edizioni Lussografica: Caltanissetta, 2010 p. 93). Anche noi facciamo, esperienza di come bellezza e visione si fondino in una presenza che ci è impossibile far cadere nell’oblio della dimenticanza, e che ci accompagnerà anche quando uscendo da questo luogo torneremo ai nostri compiti, alle nostre occupazioni.
Antonino Pileri Bruno