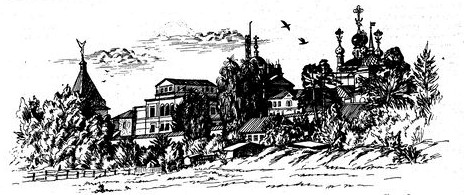Basilio Petrà, Fare il confessore oggi, Edizioni Dehoniane: Bologna, 2012
L'ambito della morale è un ambito prediletto dal prof. Basilio Petrà, e si declina nella sua produzione scientifica seguendo una doppia chiave: ecumenica e pastorale.
Il nostro autore è docente di teologia morale fondamentale e di morale familiare presso la Facoltà Teologica dell' Italia centrale (Firenze); dal 1979 è docente invitato di teologia morale patristica greca presso l' Accademia Alfonsiana (Roma); dal 1992 tiene corsi di morale ortodossa e di storia della teologia neo-greca presso il Pontificio Istituto Orientale (Roma).
Per comprendere l'attuale praxis confessarii, Petrà indugia su temi portanti della constra contemporaneità, quali lo jato tra la cultura sociale dominante e l'etica cristiana, l'imperante desiderio di emancipazione morale e la dilagante povertà di preparazione.
Lo scopo di questo saggio è offrire uno strumento utile per la qualificazione professionale del confessore, che lo avvicini agevolmente alla tradizione della Chiesa e al sentire ecclesiale (cf. p. 9). Nella trattazione della materia, pur non trascurando i doveri della ricerca attenta e meticolosa, l’autore ha l’intento di offrire un saggio che sia il più possibile di facile accesso. Il libro si rivolge per sua stessa ammissione (cf. p. 9) ai ministri della confessione. Nota di merito del saggio è l’uso puntiglioso ed attento dei documenti magisteriali.
Lo scopo di questo saggio è offrire uno strumento utile per la qualificazione professionale del confessore, che lo avvicini agevolmente alla tradizione della Chiesa e al sentire ecclesiale (cf. p. 9). Nella trattazione della materia, pur non trascurando i doveri della ricerca attenta e meticolosa, l’autore ha l’intento di offrire un saggio che sia il più possibile di facile accesso. Il libro si rivolge per sua stessa ammissione (cf. p. 9) ai ministri della confessione. Nota di merito del saggio è l’uso puntiglioso ed attento dei documenti magisteriali.
La catechesi del dopoguerra era strutturata in modo tale da consentire al catechizzando di memorizzare i doveri morali. Si assiste a un erosione della confessione tridentina, la confessione più che accusa dei peccati tende a parlare di generiche tendenze. Su relativismo etico e rudes (cf. p. 23). La catechesi del dopoguerra era strutturata in modo tale da consentire al catechizzando di memorizzare i doveri morali. Si assiste a un erosione della confessione tridentina, la confessione più che accusa dei peccati tende a parlare di generiche tendenze. Su relativismo etico e rudes (cf. p. 23). La celebrazione del sacramento della penitenza nasce da un incontro tra la grazia preveniente di Dio e l’uomo gravemente peccatore che accoglie l’invito del Signore Gesù e si converte al Vangelo. La conversione è presentata come momento dinamico. È il sinonimo del termine confessione, penitenza, ad illuminare la portata dinamica della conversione. Questa dinamica è resa evidente nella struttura della confessione sacramentale:
1) Contrizione (per avere valore salvifico deve essere originata dalla grazia soprannaturale) Cf. p 95;
2) Confessione (mediante la confessione l’uomo riconosce dinanzi a Dio e agli uomini la propria condizione di peccatore);
3) Soddisfazione (farmaco che reintegra la giustizia).
Il saggio si articola in tre nodi tematici, preceduti da una prefazione (pp. 9-11) e da una corposa introduzione (pp.13-26). I nodi tematici si dispiegano nel seguente modo: 1- Ministero presbiterale ed educazione morale della comunità cristiana (pp. 29-89); 2- Il penitente (pp. 93-114); 3- Il confessore (pp. 117-204). Segue un’appendice dedicata al problema dell’accesso dei fedeli all’eucaristia.
La prefazione sottolinea che il testo si rivolge soprattutto, ma non esclusivamente, ai sacerdoti ed offre al lettore la chiave ermeneutica del saggio. Nell’introduzione, l’autore nota come fino agli anni ΄60 vi era in Italia una convergenza tra la cultura dominante, (per quanto riguarda l'ambito socio politico sia a livello familiare che sociale) e l’insegnamento del magistero cattolico. Questa convergenza si cercò di scalzare durante il fascismo ma senza riuscirvi. Oggi si è venuta a creare una rottura tra la cultura dominante ed i contenuti etici della catechesi cristiana. È in atto una crisi tra la catechesi ecclesiale, che dovrebbe essere in grado di formare le coscienze, e le elaborazioni del sacramento.
Se da un lato il nuovo rito della confessione non introduce alcuna modifica sostanziale (cf. p. 20), dall’altro il magistero della Chiesa rimarca con chiarezza la continuità con il tridentino; si confrontino a tal proposito: il Codice di diritto canonico del 1983, l’esortazione apostolica Reconciliatio et penitentia (1984) e la lettera apostolica in forma di motu proprio dal titolo Misericordia Dei (2002). Questa mancanza di sensibilità catechetica ha portato a erodere ( cf. p. 20) la geniale portata sacramentale del sacramento della confessione. La confessione, così, tende a diventare una forma si accompagnamento spirituale. Si assiste a un contesto in cui: «”rudes” non sanno più di esserlo e i “docti” sono aumentati a dismisura» (p. 21).
Nella prima parte: Ministero presbiterale ed educazione morale della comunità cristiana, l’autore afferma che oggi non siamo più in una societas christiana e non si può più partire dal presupposto di una coincidenza tra atti di integrazione sociale e atti di integrazione ecclesiale. Si introduce la distinzione tra spazio sociale (la concreta società umana nella quale il cristiano vive con i non cattolici) e spazio ecclesiale (la realtà della chiesa nelle sue varie articolazioni). Nel corso del XX secolo il termine pastorale si è esteso dal ministero dei sacerdoti all’agire salvifico della chiesa in genere. Il capitolo secondo, introduce due concetti cardine coniugando la portata della pastoral moral guidance e la legge della gradualità. Questi due orizzonti sono sottesi da un unico principio «uno non deve mai tentare di imporre ciò che l’altra persona non può sinceramente interiorizzare, a meno che non si tratti di prevenire una grave ingiustizia ai danni di una terza persona» (p. 45). Nel capitolo terzo, il presbitero è presentato come profeta che non può tacere l’annuncio ecclesiale di Cristo. «Le virtù del presbitero sono precondizione della sua stessa capacità maieutica; nessun presbitero riuscirà a valorizzare le diverse vocazioni, i doni e i carismi della comunità se non sarà in grado di vincere l’interesse personale e il punto di vista troppo soggettivo, se non sconfiggerà la paura o il timore di perdere qualcosa di sé e del suo ruolo di capo» (pp. 63-64). Il capitolo quarto, inserisce la confessione tra i sacramenti di guarigione e percorre il dispiegarsi di questo sacramento attraverso i secoli.
La seconda parte del saggio si sofferma sulla figura del penitente. Nell’Introduzione l’autore afferma che «la celebrazione del sacramento della penitenza nasce da un incontro, l’incontro della grazia preveniente di Dio con l’uomo gravemente peccatore che accoglie l’invito del Signore Gesù e si converte al vangelo» (p. 93). Questo incontro genera la conversione nel duplice senso (negativo - positivo) di uscita dalla condizione di infedeltà e di movimento di ritorno al Signore. È proprio questo duplice senso della conversione a delineare l’evento dinamico che porta, dalla costatazione del male, al ritorno a Dio. Petrà annota puntualmente che: «Non si deve considerare la conversione, come un fatto puramente interiore; proprio in quanto evento dell’uomo, nella sua unità e integralità, essa tocca tutte le dimensioni dell’uomo. Allo stesso modo non può essere ridotta a un fatto esteriore, rituale: sarebbe una conversione apparente e periferica, non impegnando l’uomo nella sua profonda identità» (p. 94).
La seconda parte consta di tre capitoli. Il capitolo primo presenta la contrizione come atto primo del penitente; non si può rinascere senza morire (Cf. p. 95). Il secondo capitolo presenta la confessione come secondo atto del penitente. Quest’atto nasce dall’esigenza di morire al peccato e rinascere a vita nuova. (Cf. p. 99). Nella confessione «l’uomo sottrae al nascondimento il proprio peccato» (p. 99). La confessione è segno della fede, segno dell’incontro del peccatore con la mediazione ecclesiale nella persona del ministro. Il capitolo terzo presenta la soddisfazione come terzo atto del penitente. Relativamente al concetto di soddisfazione, l'autore rileva la differenza sostanziale che emerge confrontando lo stesso concetto nel primo millennio e nel secondo millennio. Mentre nel primo millennio è stata forte l’idea di soddisfazione intesa come farmaco, in stretta connessione con la figura del sacerdote, considerato dottore delle anime, nel secondo millennio la dimensione farmaceutica della soddisfazione è stata messa in ombra. (Cf. pp. 109-114).
La terza parte si sofferma sul Confessore. Nell'introduzione il confessore è presentato nella sua propria dimensione ecclesiale e la potestà di perdonare i peccati è delineata nel suo valore sacramentale. L’autore articola la riflessione su quattro capitoli. Nel primo Basilio Petrà si sofferma sul fatto che il competente (professionale!) esercizio del confessore si articola tra cuore (il cuore di padre e pastore tanto caro a S. Alfonso) e competenze (conoscenza della legge e capacità di metterla in relazione con i casi di specie). Il confessore è chiamato come giudice a valutare la conversione e come medico a perseguire la guarigione (Cf. pp. 130-131). Il secondo capitolo indugia su i doveri del confessore; declina i doveri previi alla confessione. Previamente essi consistono nella disposizione a confessare i fedeli e ad acquisire e mantenere una scienza sufficiente all’amministrazione del sacramento. Successivamente i doveri inerenti ad essa: disporre il penitente, dovere di istruire il penitente ed amministrare l’assoluzione. Il capitolo terzo delinea elementi propri della praxis confessarii, primariamente il fatto che la confessione è per la salvezza delle anime. La materia del sacramento è il peccato grave. Il confessore, importante questa sottolineatura, non è giudice delle opinioni, ma delle disposizioni del penitente (cf. p.164). Il quarto capitolo cerca di suddividere i penitenti per categorie: occasionali, scrupolosi, abituali. La seconda parte del capitolo si sofferma su dei problemi specifici: rapporti prematrimoniali, uso della contraccezione nel matrimonio, la masturbazione, l’omosessualità. In questa seconda parte un congruo numero di pagine è dedicata al problema dei divorziati risposati (cf. pp. 192-204).
Difficilmente si potrà portare avanti, negli anni a venire, una riflessione sul sacramento della confessione che possa prescindere dalla sintesi operata da questo saggio.
Antonino Pileri Bruno