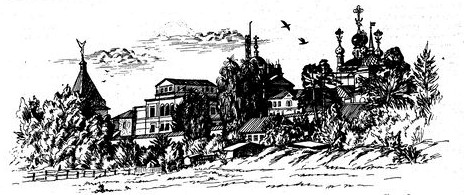Institute de Théologie Saint-Serge. La teologia ortodossa in dialogo con la modernità
Quest’anno si commemora il ventennale della morte di un grande teologo orientale: Jean Meyendorff. Mi piace ricordare l’istituzione nella quale il grande erudito esercitò la sua diaconia intellettuale l’ Istituto teologico Saint-Serge.
Nel linguaggio ecclesiastico dell’ortodossia, il termine “diaspora” si riferisce solitamente alla dispersione nel tempo e nello spazio delle comunità ortodosse che si stabiliscono in regioni diverse da quelle ove risiedono le loro chiese madri, mantenendo con queste ultime rapporti di dipendenza canonica o legami spirituali, ma cercando progressivamente di organizzarsi in maniera autonoma. Il fenomeno della diaspora ortodossa è strettamente legato a fattori di natura politica, nel caso dell’emigrazione russa, serba, rumena, armena – o economica – nel caso della diaspora greca. D’altro canto, ciascun processo di diaspora nazionale possiede caratteristiche proprie che certamente dipendono dalle motivazioni politiche e dal contesto economico, ma sono anche determinate dalle caratteristiche personali dei suoi protagonisti. (Boris Bodrinskoy, La diaspora ortodossa in Europa occidentale: un ponte tra le due tradizioni europee? in L’Ortodossia nella nuova Europa. Dinamiche storiche e prospettive, (a cura di Andrea Pacini), Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli: Torino, 2003, 303).
L’emigrazione russa del primo ventennio del novecento fu imponente. Una folla di esuli russi, tra cui un gran numero di intellettuali, fuggì dalla rivoluzione comunista. Nel dramma della lontananza dalla patria, questi uomini, trovarono nelle radici della loro fede, da un lato lo spessore della loro identità culturale, e dall’altro la capacità di entrare in relazione con la società con cui entravano a far parte. In questo contesto un ruolo davvero importante fu giocato dalle parrocchie (cf. Olivier Clément, «Petite introduction à la connaissance de l’Eglise orthodoxe» in Contacts, (n. 188), 293).
In seno al fenomeno della diaspora russa è doveroso ricordare il ruolo dell’ Istituto Saint-Serge, e non si può non associare a questa importantissima istituzione, un uomo di grande spessore umano, spirituale e culturale, Evlogij Georgievskij. Il Saint Serge deve molto alla sua capacità organizzativa, alla sua capacità di vedere lontano. Chiama attorno alla nascente istituzione teologica grandi intellettuali, mi limito a citare solo Sergeij Bulgakov, Vladimir Losskij, Vasilij Zenkovskij e Georgij Florovskij Nikolaj Afanas’ev e Pavel Evdokimov, chi conosce la teologia dell’oriente cristiano sa a quanti teologi faccia la non esaustività di questa la lista.
L’ Istituto Saint Serge stimola, dal periodo che va dalle due guerre ad oggi il rinnovamento teologico in continuità con la tradizione patristica. Questo rinnovamento vestì i panni di una scuola, una delle scuole teologiche più importanti di tutto il XX secolo: La scuola di Parigi, una scuola di grande respiro ecumenico, basti pensare accanto alla produzione della rivista del Saint-Serge, Contact, la rivista Istina, o il grande movimento intellettuale che sta dietro a Source Chrétienne.
La storia del nostro Istituto, come tutte le grandi storie è attraversata anche da momenti tragici. Nel 1931 il metropolita Evlogij, si rifiuta di piegarsi all’ultimatumdelle autorità ecclesiali moscovite e di sottoscrivere un giuramento di fedeltà alle autorità sovietiche: così la sua diocesi e l’Istituto passarono alle dipendenze canoniche del Patriarcato Ecumenico Costantinopoli. Non fu una scelta facile, così annota Jean Meyendorff:
La sua lunga fedeltà a Mosca (1922-31) e l’appello a Costantinopoli lo misero in urto con i vescovi emigrati rifugiatisi in Jugoslavia, che avevano costituito un sinodo indipendente la cui canonicità non era riconosciuta da alcuna chiesa ortodossa. (J. Meyendorff, L’Eglise orthodoxe hier et aujourd’hui, Paris, 1960, 19952, pag. 151, trad. it. La chiesa ortodossa ieri e oggi, Brescia, 1962).
Parlare del Patriarcato Ecumenico, non piò che sollecitare l’accostamento tra il ruolo della diaspora e la dimensione ecumenica che i fenomeni di inculturazione e di integrazione migratoria mettono in gioco, a tal proposito non posso che citare le sapienti parole di Boris Obolensky:
Soprattutto, non bisogna dimenticare che la cultura che gli emigrati russi portano con sé in Francia è una cultura essenzialmente europea. Le sue radici risalgono al primo stato russo formatosi tra il X e XI secolo intorno alla capitale Kiev, in una sorta d’osmosi tra gli slavi di cultura indoeuropea, i vichinghi scandinavi e l’eredità bizantina. La tradizione bizantina, con i suoi tre elementi di base (romano, greco e cristiano) divenne parte essenziale della cultura russa fino alla metà del XVII secolo. Si tratta di un patrimonio, ripeto, essenzialmente europeo: ricevendo il battesimo da Bisanzio, la Russia s’integra nella cristianità europea […] Il carattere essenzialmente europeo della sua cultura si conserva attraverso i due secoli e mezzo di dominazione mongola; dopo un certo arretramento nei secoli sedicesimo e diciassettesimo, la sua reintegrazione nella comunità europea avviene nel Settecento, con Pietro il Grande. A partire dalla metà del Settecento e fino al primo quarto dell’Ottocento, l’influenza francese domina la vita intellettuale e artistica della Russia; per molti aspetti, poi, quell’egemonia si prolunga anche al Gran secolo russo che va dalla nascita di Puškin, nel 1799, alla morte di Tolstoj nel 1910 […] Forse mai, dall’epoca medievale, la Russia colta si era sentita così intimamente e naturalmente legata all’Europa come nel ventennio che precedette la rivoluzione, durante quel periodo di straordinaria fioritura delle forze culturali del paese […] Tutto ciò segna profondamente l’ondata d’emigrazione russa in Francia degli anni intorno al 1920 […] Con la sola esclusione dell’ambito letterario, ostacolato dall’ignoranza della lingua russa e dalla mancanza di traduzioni, gli artisti (musicisti, pittori, danzatori) emigrati dalla Russia ebbero un impatto considerevole sulla società francese. (Boris Obolensky, «L’émigration russe en France» in Hommes et Migrations, n° 1124, Paris, 1989, pagg. 27-30).
Ancora tanto ha da dare l’apporto dell’ Instituto Sant-Serge, alla cristianità e all’Europa, ed è compito di noi tutti fare attenzione all’opera di questa fucina teologica che in maniera seria ed oculata accompagna il futuro della teologia dell’oriente cristiano.
Antonino Pileri Bruno