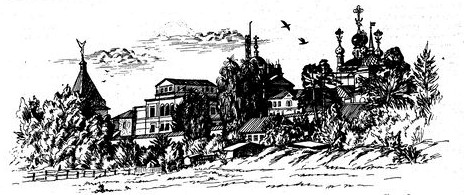Ignazio Sanna (ed.), L’etica della comunicazione nell’era digitale

Il volume pubblicato a cura dell’Area di Ricerca «teologia Filosofia Scienze Umane» dell’ ISSR Ecclesia Mater, della Pontificia Università Lateranense, in collaborazione con il Servizio Nazionale della CEI per il Progetto Culturale, raccoglie dodici saggi di cui i primi sette hanno attinenza diretta con il problema della comunicazione nell’era digitale, mentre gli ultimi cinque costituiscono gli atti di un convegno sulle implicazioni sociali e morali dell’uomo tecnologico.
Nel primo saggio di Luca Bresson, L’avvento della rete. Riflessi antropologici sull’identità umana, (pp. 21-43), l’autore declina il contesto del mutamento antropologico-culturale prodotto dalla rete, con tali parole: «L’utilizzo delle nuove tecnologie mediatiche ed informatiche non modifica soltanto i ritmi esterni della vita degli uomini; più profondamente ne modifica lo stesso modo di comprendersi come persone, di strutturare la loro identità, di comprendere il reale e il senso delle cose» (p. 22). La cultura digitale è presentata come una cultura che sta segnando il mondo in cui viviamo; l’autore afferma a tal proposito: «La cultura digitale permette ai giovani […] di vivere come variabili liberamente a disposizione della propria libertà […] elementi che nel quotidiano della vita reale e concreta invece sono fissi e non intercambiabili. […] Ad esempio, nella rete, nei social network diventa una variabile a disposizione del soggetto la definizione della propria identità, a partire da quella di genere: mi posso fingere uomo o donna, o tutti e due, a seconda del contesto in cui mi trovo inserito, e soprattutto mi posso inventare la trama della mia storia personale come meglio mi aggrada, senza vincoli apparenti» (p. 25). Più avanti afferma: «L’era digitale che stiamo esaminando si presenta davvero come un mondo da abitare, che chiede di essere, comunicare e trasmettere la propria esperienza, i loro valori, la loro saggezza» (p. 31). Il teologo lombardo sottolinea come l’utilizzo delle nuove tecnologie mediatiche modifichino non solo i ritmi esterni della vita degli uomini; più profondamente ne modifica lo stesso modo di comprendersi come persona, egli dice: «Il funzionamento spettacolare tipico di tutto l’universo digitale comporta infatti una deformazione inizialmente poco avvertita del processo metaforico che sta alla base della strutturazione simbolica del reale. (…) C’è il rischio (…) che alla fine il mondo digitale uccida la capacità di rimando al trascendente, ad un reale che ci supera e ci spiega i simboli attraverso i quali esprimiamo le nostre storie, custodiamo i nostri valori e le nostre istituzioni, costruiamo il nostro futuro individuale e comunitario». (p. 41).
Segue il saggio L’avvento di homo technologicus (pp. 45-65) di Giuseppe O. Longo, professore emerito di teoria della comunicazione presso l’Università di Trieste. In un passo fondamentale egli dice: «La tecnologia è sempre un filtro, in quanto potenzia certe caratteristiche, fisiche o cognitive, e ne indebolisce o annulla altre. In particolare, le tecnologie dell’informazione hanno potenziato le capacità razional-computanti del simbione uomo-computer a scapito delle facoltà emotive, etiche, estetiche ed espressive. Questo filtraggio provoca nel simbionte uno squilibrio e un disadattamento crescenti, che sono talora causa di rigetto e di sofferenza. La velocità sempre più elevata dell’innovazione tecnica accentua lo squilibrio e obbliga a delegare alle macchine una gamma crescente di azioni, funzioni e perfino decisioni». (p 45ss).
Segue il contributo del professore Marino Cavallo, docente di processi culturali e comunicativi presso l’Università di Bologna, dal titolo: La globalizzazione e la dinamica della società contemporanea (pp. 67-76). Ecco un passaggio che sintetizza il suo pensiero: «Le tecnologie, della vita non si limitano ad aumentare gli innesti su corpi esistenti, addirittura si spingono fino a programmare gli esiti di vite future, si spingono a progettare le caratteristiche di soggetti che debbono ancora nascere o che debbono essere ancora concepiti». (71ss).
Chiara Giaccardi, Sociologa della Cattedra di Milano, in Tra il virtuale e l’immaginario. La solitudine della rete (pp. 77-94), parla del virtuale e dell’immaginario e della conseguente solitudine della rete, affermando: «Dalla seconda decade del XXI secolo esplode il fenomeno dei social network, (…) si assiste a un interessante tentativo di superare l’individualismo mantenendo la relazione in un ambiente imersivo e “ego-centrico”, costruito sulla base di cerchie relazionali che hanno il soggetto come centro». (82ss).
Antonio Spadaro propone nel libro uno tra i saggi più riusciti: Pensare la “rete”teologicamente (pp. 95-108). Egli dice: «Oggi internet è diventato un luogo da frequentare per restare in contatto con gli amici, per condividere interessi e idee (p. 95). Internet è un “ambiente” culturale, che determina uno stile di pensiero (p. 95). La Rete più che “mezzo di evangelizzazione è innanzitutto un contesto in cui la fede è chiamata ad esprimersi non per una mera “volontà di presenza”, ma per una connaturalità del cristianesimo alla vita degli uomini. La sfida della Chiesa non deve essere quella di come “usare bene” la Rete, come spesso si crede, ma come “vivere” bene al tempo della Rete (p. 96), e più avanti: «E’ dunque necessario educare le persone al fatto che ci sono domande che sfuggono sempre e comunque alla logica del “motore di ricerca”, e che la “googlizzazione” della fede è impossibile perché falsa». (p. 98).
Il libro è arricchito da un ulteriore contributo realizzato dal professore Massimiliano Padula, docente di comunicazione istituzionale presso la Lateranense, dal titolo: L’era digitale: etica della comunicazione e diritto all’oblio. In un passo fondamentale egli dice: «L’oblio è un atto mnemonico quindi biologico, ma anche sociale e antropologico. L’oblio ha anche implicazioni giuridiche, economiche e politiche». (117 ss).
Michele Sorice, docente di sociologia della comunicazione presso la LUISS di Roma, nel suo saggio Social media e chiesa. Il tempo del dialogo (pp. 123-141), inquadra i Social Network come straordinario strumento di riflessione che interpella la Chiesa a passare dalla logica della trasmissione della fede a quella del dialogo. In un passo chiave afferma: «Come apparirà evidente da questa rapida descrizione della situazione contemporanea, internet (e il web 2.0 in particolare) sono luoghi simbolici che hanno visto crescere in maniera vorticosa le pratiche di networking, diventate in molti casi degli strumenti di incremento della partecipazione. Nuove forme di partecipazione sociale e nuovi modi di vivere la propria cittadinanza si sono affacciati e ormai consolidati. Pur evitando facili quanto pericolose forme di ottimismo acritico, è tuttavia evidente che alcuni cambiamenti costituiscono una grande opportunità per la Chiesa». (135ss).
Ignazio Sanna, nel suo contributo Fede e scienza dopo Ratisbona (pp. 143-163), sottolinea come la problematica del corretto rapporto tra fede e ragione, così come tra razionalità teologica e razionalità scientifica, in realtà, sia stata sempre presente nel confronto del cristianesimo con la modernità [Cf. p.143]. Egli dice: «Le scienze hanno trasferito la fonte della dignità dell’uomo dalla sfera teologica e da quella filosofica a quella biologica, dove non si accetta alcun limite di intervento, perché una volta che si è distrutto il concetto di “natura”, tutto diventa artificiale e quindi manipolabile e non ha più senso parlare di un limite “naturale” di azione». (p. 152).
Paolo M. Cattorini, docente di bioetica all’Università dell’Insubria, nel suo contributo Quantità e qualità della vita. Vita più lunga o vita più felice? (pp. 165-178), tratta del tema del desiderio di una vita lunga e felice, cioè buona. Egli dice: «Vogliamo una vita lunga e felice. Più esattamente vogliamo che la vita buona, il termine ultimo del nostro desiderio, sia connotata per quanto possibile da questi due caratteri». (p. 165ss).
Paul O’Callaghan, docente di Antropologia Teologica presso l’Università della Santa Croce in Roma, nel suo saggio Tutto l’uomo diventerà immortale? (pp. 179-205), tratta dell’immortalità come bisogno istintivo dell’uomo. Egli dice: «Cullmann ha affermato che la chiave per capire la dottrina escatologica cristiana non è l’immortalità dell’anima, ma piuttosto la resurrezione dei morti. Nella mente di molti cristiani, tuttavia, la prima è andata ad occupare il posto della seconda». (p. 188).
Carlo Cirotto, citologo presso l’Università di Perugia, nel suo contributo L’identità della specie tra il naturale e l’artificiale, (pp. 207-221), tratta della difficoltà di definire una specie, egli a tal proposito afferma: «Che cos’è una specie? È, questa, una domanda che i biologi continuano a porsi da moltissimo tempo senza, purtroppo giungere ad una risposta conclusiva. Neanche oggi, epoca della biologia molecolare, che sonda la struttura più intima degli organismi, e dell’informatica, che consente calcoli astronomici in tempi brevissimi, è possibile dare una soluzione obiettiva e soddisfacente al problema [p. 207], e più avanti: «Una cellula sintetica, una forma di vita davvero artificiale, non è stata ancora creata in laboratorio. Questo però è lo scopo ultimo, la finalità alla quale guardano i bio-ingegneri, convinti che riuscire a riprodurre in modo del tutto artificiale una cellula significhi comprendere il segreto della vita. Non so se mai si riuscirà nell’intento né se ciò possa, di per sé, portare a svelare il segreto della vita. Di certo, però, ciò che ha fatto Venter ben esprime quel cortocircuito artificiale-naturale che un tempo passava per i Chopper e che passa ora per la modifica dei meccanismi più segreti della vita». (p. 221).
Maurizio P. Faggioni, docente di bioetica all’Accademia Alfonsiana, nel saggio Natura ed artificio nella procreazione assistita, (pp. 223-250), riflette sugli interventi biomedici nel campo della procreazione. Le regole morali nell’uso della tecnica non vanno ricercate nella tecnica stessa, ma nel progetto morale in cui questa tecnica si colloca. Egli, in un passo afferma: «Le regole morali della uso della tecnica non possono, quindi, essere trovate nella tecnica stessa, ma vanno ricercate nel progetto morale in cui una certa tecnica si colloca e, ultimamente, nell’idea di vita buona che un tale progetto implica. La tecnica può riflettere un progetto di autenticità e di servizio della persona o diventare espressione della logica interna del desiderio che è quella di essere massimamente soddisfatto». (p. 250).
Il testo compaginato in dodici contributi, si presenta esaustivo e coerente con le finalità che si propone, esso costituisce un contributo significativo per le problematiche etiche e sociali dell’epoca contemporanea.
Antonino Pileri Bruno