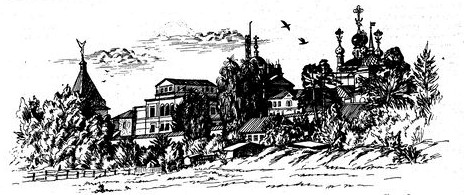Cristianesimo ed ebraismo. Storia di incontri e di incomprensioni
+di+Copia+di+sanPaolo.jpg)
Il cristianesimo delle origini è profondamente radicato nell'ebraismo e non può essere compreso senza avere contemporaneamente una sincera simpatia e un'esperienza diretta del mondo ebraico. Gesù è pienamente ebreo, ebrei sono gli apostoli, e non si può dubitare del loro attaccamento alla tradizione dei padri. La pasqua messianica che Gesù, redentore universale e servo sofferente, annuncia e realizza, non si oppone all'alleanza del Sinai, ma ne completa il senso. Carlo Maria Martini
«Verso la metà del primo secolo il mondo romano cominciò ad accorgersi che nel suo seno era cresciuta una nuova comunità, i cui membri furono indicati col nome di cristiani» (Ruth Rouse-Stephen Charles (edd.), Storia del movimento ecumenico dal 1517 al 1948, Società editrice il Mulino: Bologna, 1973, 19). Basti a tal proposito ricordare quanto in riferimento ai cristiani afferma Tacito:
«Verso la metà del primo secolo il mondo romano cominciò ad accorgersi che nel suo seno era cresciuta una nuova comunità, i cui membri furono indicati col nome di cristiani» (Ruth Rouse-Stephen Charles (edd.), Storia del movimento ecumenico dal 1517 al 1948, Società editrice il Mulino: Bologna, 1973, 19). Basti a tal proposito ricordare quanto in riferimento ai cristiani afferma Tacito:
«I Cristiani erano di fatto leali cittadini, però avevano una religione strana e nuova che comportava anche atteggiamenti di isolamento, come la non partecipazione ai giochi, agli spettacoli, e di segregazione, come le adunanze segrete e per soli adepti. [...]A questa avversità non va disgiunta la lotta dei giudei che Tertulliano definisce come Seminarium infamiae nostrae. Sotto la spinta di queste avversità si spiega l'intervento statale nel colpire gli esponenti maggiori dei cristiani». (Tacito, Annali, XV, 44, 2-5).
Il cristianesimo si sviluppa all'interno del mondo ebraico. La prima comunità cristiana è formata da ebrei che hanno riconosciuto Gesù di Nazaret come il Messia. La prima grande separazione, nel seno della chiesa nascente, deve essere considerata la separazione tra i discepoli di Gesù, che da Antiochia avevano cominciato ad essere indicati come cristiani (cf. At 11, 26) e coloro che non avendo riconosciuto Gesù come il Messia avevano continuato ad essere ebrei (si noti che queste tensioni traspaiono nei testi di s.Paolo). Separandosi dall'ebraismo, la comunità cristiana aveva portato con sé non solo la Sacra Scrittura, ma tutto un patrimonio spirituale e liturgico. Questa separazione comportò tensioni in seno alla stessa comunità dei discepoli di Gesù, che si dividevano nelle due correnti dei “giudeizzanti” ed “ellenisti” che ritenevano superato il giudaismo con le sua legge e le sue istituzioni.
Società di amore e di fede, quella cristiana era anche una società unita nel culto. Nei primissimi tempi i cristiani continuarono a frequentare fedelmente il tempio e la sinagoga e, anche quando la rottura con il giudaismo fu definitivamente consumata, seguitarono ad osservare in molte cose le antiche tradizioni ebraiche. (Ruth Rouse-Stephen Charles (edd.), Storia del movimento ecumenico dal 1517 al 1948, Società editrice il Mulino: Bologna, 1973, 21).
La posizione espressa dal Concilio di Gerusalemme (At 15) volle costituire una linea di mediazione che sarà tenuta da Pietro, Paolo e dagli altri apostoli e che si esprimerà nelle Scritture della nuova comunità che prenderanno il nome di Nuovo Testamento. «Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi nessun altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie:astenervi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla impudicizia. Farete quindi cosa buona a guardarvi da queste cose. State bene». (At 15, 28-29)
Le frange più estreme degli “ellenisti” confluiranno nelle correnti degli encreatiti («L'encreatismo […] comportava una condanna formale del matrimonio e un appello agli sposi a separarsi», in Jean Daniélou, La teologia del giudeo-cristianesimo, Edizioni Dehoniane: Bologna, 128) e degli gnostici, (cf. Jean Daniélou, La teologia del giudeo-cristianesimo, Edizioni Dehoniane: Bologna, 527-533) mentre le comunità giudaizzanti costituirono una chiesa giudeo-cristiana, che si affermerà in Palestina e nell'area siriaca, ma che, esclusa dalle sinagoghe (cf. Gv 9, 22 questo brano sembra anticipare all'epoca di Gesù una situazione che si verificherà di fatto alla fine del primo secolo), e con esigui contatti con le altre comunità cristiane, venne probabilmente ad estinguersi fra il IV e il V secolo.
Un tale radicale allontanamento dalla matrice ebraica, unita alle tensioni che nel corso dei primi secoli si ebbero tra le comunità ebraiche, e quelle cristiane perseguitate spesso esposta a istigazione di pagani o anche di ebrei, fece sì che l'incomprensione diventasse la regola nei rapporti tra cristiani ed ebrei. Una volta divenuta religione di Stato, (Editto di Tessalonica del 380) furono i cristiani a instaurare un regime di oppressione e di persecuzione nei confronti degli ebrei.
Antonino Pileri Bruno