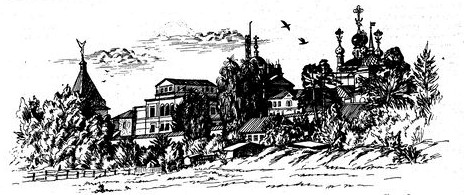Le controversie dottrinali affrontate nei primi concili

Appena il messaggio evangelico si diffuse in tutto il bacino del mediterraneo si incontrò con la filosofia greca e con il diritto romano. L'incontro del cristianesimo con la cultura greco-romana offrì alla nuova religione la possibilità di esprimere l'insegnamento cristiano nelle categorie filosofiche tanto care a questa cultura. L'insegnamento della dottrina cristiana formalizzata nelle categorie filosofiche portò allo svilupparsi di tensioni che sfociarono nell'enucleazione di eresie, alcune delle quali, come la gnosi, costituirono una minaccia fortissima per la comunità cristiana nascente.
Molte comunità si separarono dalla grande Chiesa, a causa di alterazioni di alcuni insegnamenti della fede cristiana. Nessuna di tali comunità, fra le quali possiamo annoverare i marcioniti e i montanisti nel secondo secolo, i novazioni nel III secolo, i donatisti e i pelagiani fra il IV e il V sopravvisse a lungo.
Le controversie dottrinali più incisive furono le controversie che cercarono di mettere in chiaro la persona di Cristo, cercando di rispondere al problema del rapporto che esiste fra Dio e il Verbo di Dio (Gv 1, 1-14), in altre parole al problema trinitario; e a quello del rapporto che intercorre tra il Verbo e la “carne” (Gv 1, 14), fra la divinità e l'umanità di Cristo. Queste controversie portarono alla celebrazione dei primi grandi concili ecumenici. Riguardo ai rapporti esistenti fra Dio e il Cristo, diverse erano le soluzioni proposte, tanto nella linea ortodossa, quanto in un quella eterodossa. Queste posizioni eterodosse furono indicate come “adozionismo” (Gesù sarebbe un semplice uomo adottato da Dio al battesimo, o deificato alla Resurrezione), “monarchianesimo” (Padre e Figlio come un unica persona), “patripassianesimo” (è il Padre stesso che ha patito sulla croce), “modalismo” (Padre, Figlio e Spirito come diversi “modi” dell'unico Dio). L'interpretazione che appare chiaramente contraria all'insegnamento della Scrittura appare l'arianesimo, che afferma la subordinazione del Figlio al Padre, quasi come sua creatura; una dottrina che prese il nome da Ario, presbitero di Alessandria, vissuto agli inizi del IV secolo.
Per esprimere una posizione decisa contro l'arianesimo venne celebrato il Concilio di Nicea, celebrato nel 325. Tale Concilio condannò l'arianesimo, affermando che il Figlio è homoousios, consustanziale, e cioè della sostanza del Padre. Nonostante la condanna, tale eresia ebbe una grande diffusione nei decenni successivi. Il concilio di Costantinopoli del 381, sinodo orientale la cui portata fu riconosciuta in seguito, affermava la divinità dello Spirito Santo, contro i “pneumatomachi”, facendo proprie l'affermazione di Basilio: Dio è una sola sostanza in tre persone distinte. Esso portò a compimento la formulazione del simbolo che conosciamo come credo niceno costantinopolitano.
Le più antiche comunità cristiane, che si sono separate dalla comunione della grande Chiesa si sono staccate nel corso del V secolo a seguito delle controversie cristologiche che condussero alla celebrazione del concilio di Efeso del 431 e poi quello di Calcedonia del 451. Il concilio di Efeso si pose il problema dell'unità personale di Gesù Cristo. Tale concilio si concluse con la condanna di Nestorio, patriarca di Costantinopoli. Lo stesso concilio riconobbe la legittimità del titolo di Theotòkos attribuito a Maria.
Il concilio di Calcedonia (451) condannò l' eresia del “monofisismo”, la tendenza cioè a trascurare o a negare la presenza di una natura umana in Gesù Cristo. Questo concilio formulò la fede cristiana in espressioni che attraverso i secoli sono giunte fino a noi: Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, una sola persona in due nature, la natura umana e la natura divina, distinte e inconfuse, ma fra loro comunicanti (comunicatio idiomatum).
Antonino Pileri Bruno