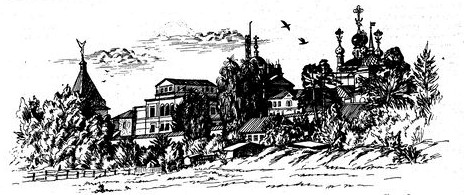La riforma e i suoi esiti per la chiesa d'occidente

La frattura tra occidente ed oriente rappresentò un grave vulnus per la cristianità. La chiesa d'oriente conservò anche dopo la separazione della chiesa d'occidente la fede e la struttura ecclesiale dei primi secoli, ma restò in un grave stato di subordinazione rispetto alle autorità statuali. La chiesa d'occidente grazie all'accentuazione del primato papale, acquistò una nuova indipendenza dalle autorità statuali. Proprio questa centralizzazione, ed il prevalere degli aspetti giuridici, preparò quella che dev'essere considerata la più grave lacerazione del tessuto della Chiesa d'occidente, la lacerazione della Riforma.
Per molti secoli, all'interno della Chiesa d'occidente, era stata infatti invocata una riforma della Chiesa, in fide et in moribus, in capite et in membris. Questa aspirazione alla riforma si era espressa in innumerevoli movimenti laicali, da cui alcuni, come i valdesi, erano stati condannati, mentre altri erano stati accolti portando a un notevole rinnovamento ecclesiale (francescani e altri ordini mendicanti). Questa aspirazione fatta sentire nei concili all'inizio del XV secolo, ed era stata fatta propria dal papato.
Il concilio di Basilea aveva anche preso tutta una serie di decisioni in ordine alla riforma della chiesa. Purtroppo con papa Eugenio IV dopo che egli aveva sospeso il concilio e ne aveva deciso il trasferimento a Ferrara e poi a Firenze ebbe come conseguenza una gravissima lacerazione della cristianità dell'occidente, che costituì forse l'ostacolo maggiore a una reale ricezione delle decisioni di Firenze e che anticipò di circa un secolo la divisione della Riforma. Di fatto nessuna riforma adeguata poté essere messa in atto, l'accumularsi di tutta una serie di fattori, formarono una miscela esplosiva, nella quale pesonalità come Lutero, Zwingli e Calvino, agirono da detonatori.
I fattori teologici, con la centralità del principio della giustificazione per grazia mediante la fede e con l'appello diretto alla Scrittura come ultima autorità della fede, svolsero un ruolo molto più determinante di quanto non fosse accaduto nella separazione con l'oriente. I fermenti riformatori, che erano presenti nella chiesa cattolica già da molti decenni (si pensi ad esempio alla figura di Caterina da Genova), trovarono finalmente modo desprimersi anche ai più alti livelli, dando origine a un epoca di risveglio e di rinnovamento, che si concretizzò nel concilio di Trento (1545-1563). Il rinnovamento deciso dal concilio di Trento venne tradotto in atto, grazie all'azione pastorale di vescovi riformatori, quali Carlo Borromeo e Francesco di Sales, ma soprattutto grazie al sorgere di molti ordini e congregazioni religiose, in particolare dei gesuiti.
Antonino Pileri Bruno