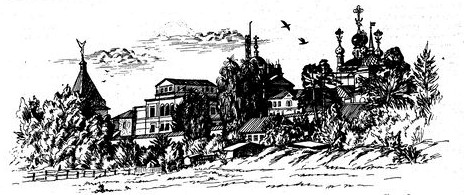Le vie per stabilire l'unità nel corso della storia

La storia della chiesa ha visto un avvicendarsi di conflitti e di divisioni senza che tuttavia si sia mai incrinato del tutto il senso di una fraternità profonda fondata sull'unica fede in Cristo e sull'unico battesimo. Questo senso di una comune appartenenza ha fatto sì che la stessa comunità cristiana non si sia mai rassegnata a queste divisioni.
Nelle primissime comunità cristiane, la pienezza di fede e di carità, consentiva di integrare tutte le differenze, di cultura, di sesso, di condizione sociale, vivendo la comunione all'interno della comunità, superando le divisioni esistenti fra i cristiani provenienti dall'ebraismo e i cristiani provenienti dall' ambiente greco vincendo le tentazioni settarie. La salvaguardia della comunione a livello locale costituiva la principale preoccupazione. Il disegno di Dio intorno alla chiesa, quale emerge dall'insieme del Nuovo Testamento, è quindi un disegno di koinonìa, che implica dimensioni di comunione interiore ma anche visibile. I discepoli del Signore devono praticare concretamente la carità, riconoscendosi e trattandosi da fratelli nelle relazioni quotidiane.
Nei rapporti tra le diverse comunità cristiane si conservava la comunione senza far ricorso a strumenti giuridici, anche perché le comunità avevano una dimensione ridotta e le comunicazioni all'epoca non erano quelle che conosciamo oggi. Partecipando della stessa fede e tradizione apostolica, ogni comunità si sentiva naturalmente in comunione con le altre comunità cristiane, ed esprimeva tale comunione in relazioni fraterne, nella pratica dell'ospitalità, nell'accoglienza dei missionari itineranti, nello scambio di lettere, talvolta nelle collette e nell'aiuto materiale.
I ministeri, in primis il ministero presbiterale ed episcopale, erano intesi come ministeri al servizio della comunione, tanto all'interno della singola comunità, nella quale il vescovo costituiva il punto di riferimento visibile (Ignazio di Antiochia), quanto nei rapporti con le altre comunità. Questo rapporto si esprimeva con la partecipazione dei vescovi all'ordinazione dei nuovi vescovi. A poco a poco emerse la struttura metropolitana e patriarcale e si esplicitò sempre più il primato della sede di Roma, la città nella quale gli apostoli Pietro e Paolo avevano reso la testimonianza del sangue e il cui vescovo si vedeva riconosciuto il compito di “presiedere nella carità” alla comunione delle chiese, secondo la bella espressione che troviamo in Ignazio di Antiochia sin dagli inizi del secondo secolo.
Con riferimento al comportamento degli apostoli, in occasione della controversia fra giudeocristiani ed ellenocristiani, quale ci viene mostrato da At 15 la risoluzione di eventuali controversie veniva affidata a incontri fra responsabili di chiese, ben presto indicati come sinodi o concili, e che vennero riuniti dapprima a livello locale, e poi a un livello sempre più ampio, sino ad arrivare con il quarto secolo alla convocazione di quei concili, che saranno riconosciuti in seguito come universali o ecumenici.
L'esistenza di questo pluralismo nella comunione agli inizi della storia della chiesa è riconosciuta dal Concilio Vaticano II, che sembra presentare questa forma di rapporti all'interno della comunità cristiana come non solo legittima ma anche esemplare: «Le chiese d'oriente e d'occidente hanno seguita per molti secoli una propria via, unite però dalla fraterna comunione della fede e della vita sacramentale, intervenendo per comune consenso la sede romana, qualora fossero sorti fra loro dissensi circa la fede e la disciplina» (UR 14).
Antonino Pileri Bruno